

PARLIAMO DI....
LA
PASSIONE POLITICA DI NANDO GIAMBRA
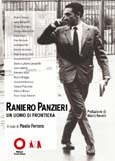 Non
è soltanto una pagina di storia politica quella che evoca Nando Giambra nella
testimonianza pubblicata (assieme a quelle di Goffredo Fofi, Mario Tronti, Marco
Revelli ed altri altolocati personaggi della politica e della cultura nazionale)
nell’ultimo libro su Panzieri (“Raniero Panzieri, uomo di frontiera”, a
cura di Paolo Ferrero, Edizioni PuntoRosso/Carta, Milano, 2005, € 13 – www.puntorosso.it).
I grevi tempi in cui viviamo, dileggiando valori quali passione politica, rigore
intellettuale ed altruismo, ci spingono verso una chiave di lettura che si
dipana sul filo della tensione ideale che animò la migliore gioventù siciliana
del dopoguerra.
Non
è soltanto una pagina di storia politica quella che evoca Nando Giambra nella
testimonianza pubblicata (assieme a quelle di Goffredo Fofi, Mario Tronti, Marco
Revelli ed altri altolocati personaggi della politica e della cultura nazionale)
nell’ultimo libro su Panzieri (“Raniero Panzieri, uomo di frontiera”, a
cura di Paolo Ferrero, Edizioni PuntoRosso/Carta, Milano, 2005, € 13 – www.puntorosso.it).
I grevi tempi in cui viviamo, dileggiando valori quali passione politica, rigore
intellettuale ed altruismo, ci spingono verso una chiave di lettura che si
dipana sul filo della tensione ideale che animò la migliore gioventù siciliana
del dopoguerra.
Nando Giambra nasce a Valguarnera nel 1929 da famiglia di piccola borghesia (papà calzolaio divenuto commerciante). Adolescente, è confrontato alla miseria che imperversa in paese; miseria sedimentata ed acuita dai disastri bellici. Come alcuni decenni prima era successo a Girolamo Valenti, egli respinge la tentazione del salto verso il blocco sociale dominante prendendo invece a cuore le sorti dei ceti popolari. Una visione più romantica che politica, come sarà notato più tardi. A vent’anni, studente presso l’Università di Catania, si entusiasma per la lotta politica ed entra nel partito socialista. Sente subito parlare di un giovane professore dell’Università di Messina che “la mattina alle quattro occupava le terre e alle dieci entrava in aula ad insegnare”. Era Raniero Panzieri, un mito per molti giovani siciliani.
Panzieri non aveva ancora trent’anni, ma – dotato di un’intelligenza e di un rigore scientifico fuori del comune - era già stato chiamato da Morandi a dirigere l’Istituto di Studi socialisti a Roma e poi da Della Volpe ad insegnare Filosofia del diritto a Messina. L’incontro è una sorta di colpo di fulmine. Dopo una riunione politica, i due si vedono in privato: “mettendomi a completo agio – racconta Nando - riuscì a sapere tutto di me: la breve storia personale, gli studi, le origini e l’ambiente sociale dal quale venivo, la brevissima esperienza di lotta all’Università, cosa pensassi e come mi trovavo con il gruppo di compagni. Mi fece una raccomandazione: non perdere mai i legami della mia origine con braccianti e zolfatari”. Si iscrive dunque nella natura delle cose la proposta di entrare nell’organico del partito, destinato a Siracusa. Nando accetta: “A 22 anni non ancora compiuti, Raniero mi mise in mano quindicimila lire e il 14 luglio 1951 partivo per Siracusa (le seconde quindicimila lire riuscì a darmele in novembre!)”. Dramma in famiglia, naturalmente. Papà intuisce che la scelta di diventare “rivoluzionario di professione” avrebbe vanificato la prospettiva della laurea e con essa anni di sacrifici. Mamma, invece, non manca di inviare nella città aretusea “emissari segreti” che verificassero le condizioni del figlio e gli consegnassero un po’ di risparmi. I problemi economici, infatti, non sono metaforici, se è vero quanto scrive la moglie di Panzieri: “Ogni tanto Raniero telefonava alla padrona di casa, mi faceva chiamare e mi diceva: senti, prepara qualcosa da mangiare perché Mimmo (Rizzo) e Nando (Giambra) non hanno un soldo in tasca e non possono neanche mangiare”. Panzieri è dunque sempre sullo sfondo a vigilare, non solo politicamente, su quello che è ormai diventato uno dei “suoi giovani”.
Nel 1952, l’anno successivo, viene trasferito alla federazione di Enna (suo dirimpettaio, in quella comunista, è l’economista Napoleone Colajanni), cosa che gli consente di occuparsi da vicino del proprio paese: “In quel periodo gli zolfatari erano in lotta e le sezioni locali del Psi e del Pci chiesero alle rispettive federazioni di mandare me a fare un comizio. Erano altri tempi: un’ora prima, i lavoratori interessati, con la banda musicale in testa, giravano per il paese in corteo per invitare i cittadini ad andare al comizio. Quella volta la curiosità di ascoltare “un ragazzo dei nostri” fu tale che la piazza si riempì fino all’inverosimile e tutti i balconi prospicienti erano affollati di donne (le manifestazioni politiche in piazza erano riservate agli uomini!). Il comizio fu un enorme successo. Moltissime persone, di tutte le parti politiche, sfollando dalla piazza passarono dal negozio di papà congratulandosi per il figlio. Da quella sera tornò la pace in famiglia”. Alle prime comunali, viene eletto consigliere, ma si dimette presto perché trasferito alla federazione di Palermo, dove ritrova Panzieri. Prima di partire, ha la soddisfazione di constatare il successo del suo tentativo di far passare il rapporto tra i partiti di sinistra e i democristiani dall’anatema al piano politico. E questo grazie ai suggerimenti di Raniero e alla presenza di Carmelo Giarrizzo “un artigiano di grande acume politico che dirigeva la locale sezione della Dc”.
Dopo l’esperienza palermitana, il passaggio al sindacato: apprendistato a Verona e poi alla Camera del lavoro di Catania. Segretario regionale è Emanuele Macaluso che lo nota e lo candida al Direttivo Nazionale. E’ la volta di un’altra esaltante pagina di vita politica vissuta sotto l’autorevole sguardo di Giuseppe Di Vittorio. Una “militanza itinerante” che lo porta a Vicenza, a Roma, e poi di nuovo a Vicenza, separando la sua strada da quella del maestro. D’altronde i tempi sono cambiati. Panieri si scontra apertamente con Nenni e viene spinto fuori dal partito. Fonda “Quaderni rossi” ed anima quelle ricerche politiche e sociologiche, imperniate sulla condizione operaia, che costituiranno uno dei filoni più fecondi della cultura del Sessantotto. Nando, invece, cesserà di fare il funzionario per aprire una piccola impresa commerciale a Verona. Sempre, però, animato dalla passione politica e coerente con la scelta fatta durante la gioventù valguarnerese, divenuta “un patrimonio per la vita”. “Oggi in piena serenità”, afferma, “divenuto padre e nonno, posso affermare di non essermi mai pentito di quella scelta”. E noi ti ringraziamo, Nando.
Enzo
Barnabà