
PARLIAMO
DI....
CRISTO
SI È FERMATO A PAPARANZA?
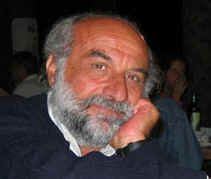 Curando
per questo sito la rubrica “Un proverbio alla settimana”, che trae origine
da un repertorio di aforismi nostrani raccolti e commentati dal dott. Francesco
Giarrizzo, mi sono improvvisamente rivisto adolescente nella mia casa di via
Treves con in mano un libro dalla copertina bordata di rosso ed i fogli di carta
grigiastra, quello di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario:
“Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Niente è meno cristiano,
infatti, di massime quali Nan far’ ben’ ch' mal’ t’ n’ ven’ o
Cu
av’ pena d’ i carn’ d’ l’àutr’, i suwi s’i màngian’ i can’
(con la variante: Cu av’ pena
d’ l' àutr’, a so pedd’ s’ a màngian’
i can’) o ancora Cu
d’ sceccu fa cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so (con
la variante Cu r’ a pe u minta a cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so).
La carità cristiana e l’amore per il prossimo vengono fatti a pezzi da queste
pillole di saggezza (così vengono abitualmente definiti i proverbi, ma sarebbe
meglio usare in questo caso la parola “ideologia”) popolare. La chiusura
egoistica sconfigge anche il familismo, abitualmente saldissimo pilastro del
mondo referenziale isolano: Sa ch’ serv’
e to djnt’ na n
dar’ e to parjnt’.
Curando
per questo sito la rubrica “Un proverbio alla settimana”, che trae origine
da un repertorio di aforismi nostrani raccolti e commentati dal dott. Francesco
Giarrizzo, mi sono improvvisamente rivisto adolescente nella mia casa di via
Treves con in mano un libro dalla copertina bordata di rosso ed i fogli di carta
grigiastra, quello di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario:
“Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Niente è meno cristiano,
infatti, di massime quali Nan far’ ben’ ch' mal’ t’ n’ ven’ o
Cu
av’ pena d’ i carn’ d’ l’àutr’, i suwi s’i màngian’ i can’
(con la variante: Cu av’ pena
d’ l' àutr’, a so pedd’ s’ a màngian’
i can’) o ancora Cu
d’ sceccu fa cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so (con
la variante Cu r’ a pe u minta a cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so).
La carità cristiana e l’amore per il prossimo vengono fatti a pezzi da queste
pillole di saggezza (così vengono abitualmente definiti i proverbi, ma sarebbe
meglio usare in questo caso la parola “ideologia”) popolare. La chiusura
egoistica sconfigge anche il familismo, abitualmente saldissimo pilastro del
mondo referenziale isolano: Sa ch’ serv’
e to djnt’ na n
dar’ e to parjnt’.
Ritroviamo
qui - mi sembra - quel rovesciamento di valori di cui parla Italo Calvino a
proposito dei mimi lanziani a sfondo religioso. Se il Vangelo racconta una
storia umana riferendola a un significato sacro, l’aneddoto paesano fa
“insorgere i segni profani contro il sistema dei simboli sacri”
(Introduzione ai “Mimi siciliani” editi da Sellerio nel 1971), compiendo
l’operazione simmetrica che largamente rintracciamo in questi proverbi. Se
sostituiamo, infatti, le parole chiavi dei citati aforismi con il loro
contrario, entriamo con chiarezza nel pieno della morale evangelica.
Il
Cristo di Levi, com’è noto, si ferma alla lontana stazione ferroviaria,
tagliando fuori l’immobile millenaria civiltà dei contadini della Basilicata;
è la Storia, insomma. Il nostro – quello che (salvo non rare vittoriose
incursioni) ha dovuto fermarsi a Paparanza – è invece il Cristo storico, il
cui messaggio non è riuscito a conquistare il nostro paese (nè gli altri paesi
dell'interno siciliano, beninteso) avendo trovato strenui resistenze. E queste
resistenze da dove provengono? Sono vigorose sopravvivenze del paganesimo oppure
ordinari comportamenti di chi crede che la lotta per la vita non accetti freni,
che l’uomo sia sostanzialmente rimasto la bestia primordiale cui è estraneo
in concetto di solidarietà (l’“homo homini lupus” di scolastica memoria,
per intenderci)?
Nel
memorabile saggio “Feste religiose in Sicilia”, Leonardo Sciascia, scuotendo
pigre certezze, sosteneva la refrattarietà del popolo siciliano alla
trascendenza. E alla spiritualità? viene da chiedersi. Ovvero, la religiosità
praticata è soltanto ritualità sociale (si pensi, tra l’altro, allo sfarzo
della tavola di San Giuseppe o dell’altarino del Corpus Domini, utilizzati
quali status symbol) e “do ut des” (lo scambio tra il fedele e il Santo al
fine di veder risolti quotidiani problemi) o è animata anche da altro?
Sembrerebbe che il cattolicesimo, così come ha storicamente preso corpo dalle
nostre parti, si sia limitato a dare qualche pennellata di superficie lasciando
immutata la sostanza. Chissà se qualcuno saprà dar risposta a queste domande
che mi faccio e faccio.
Enzo
Barnabà



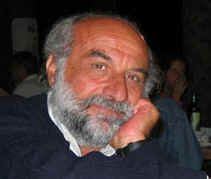 Curando
per questo sito la rubrica “Un proverbio alla settimana”, che trae origine
da un repertorio di aforismi nostrani raccolti e commentati dal dott. Francesco
Giarrizzo, mi sono improvvisamente rivisto adolescente nella mia casa di via
Treves con in mano un libro dalla copertina bordata di rosso ed i fogli di carta
grigiastra, quello di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario:
“Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Niente è meno cristiano,
infatti, di massime quali Nan far’ ben’ ch' mal’ t’ n’ ven’ o
Cu
av’ pena d’ i carn’ d’ l’àutr’, i suwi s’i màngian’ i can’
(con la variante: Cu av’ pena
d’ l' àutr’, a so pedd’ s’ a màngian’
i can’) o ancora Cu
d’ sceccu fa cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so (con
la variante Cu r’ a pe u minta a cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so).
La carità cristiana e l’amore per il prossimo vengono fatti a pezzi da queste
pillole di saggezza (così vengono abitualmente definiti i proverbi, ma sarebbe
meglio usare in questo caso la parola “ideologia”) popolare. La chiusura
egoistica sconfigge anche il familismo, abitualmente saldissimo pilastro del
mondo referenziale isolano: Sa ch’ serv’
e to djnt’ na n
dar’ e to parjnt’.
Curando
per questo sito la rubrica “Un proverbio alla settimana”, che trae origine
da un repertorio di aforismi nostrani raccolti e commentati dal dott. Francesco
Giarrizzo, mi sono improvvisamente rivisto adolescente nella mia casa di via
Treves con in mano un libro dalla copertina bordata di rosso ed i fogli di carta
grigiastra, quello di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario:
“Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Niente è meno cristiano,
infatti, di massime quali Nan far’ ben’ ch' mal’ t’ n’ ven’ o
Cu
av’ pena d’ i carn’ d’ l’àutr’, i suwi s’i màngian’ i can’
(con la variante: Cu av’ pena
d’ l' àutr’, a so pedd’ s’ a màngian’
i can’) o ancora Cu
d’ sceccu fa cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so (con
la variante Cu r’ a pe u minta a cavadd’, u prìm’ càuc’ è u so).
La carità cristiana e l’amore per il prossimo vengono fatti a pezzi da queste
pillole di saggezza (così vengono abitualmente definiti i proverbi, ma sarebbe
meglio usare in questo caso la parola “ideologia”) popolare. La chiusura
egoistica sconfigge anche il familismo, abitualmente saldissimo pilastro del
mondo referenziale isolano: Sa ch’ serv’
e to djnt’ na n
dar’ e to parjnt’.