|
|
|
|
|
|
|
|
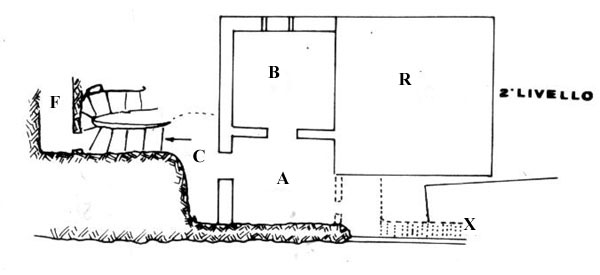
Visto
che la rampa d’accesso ai piani superiori (rampa forse 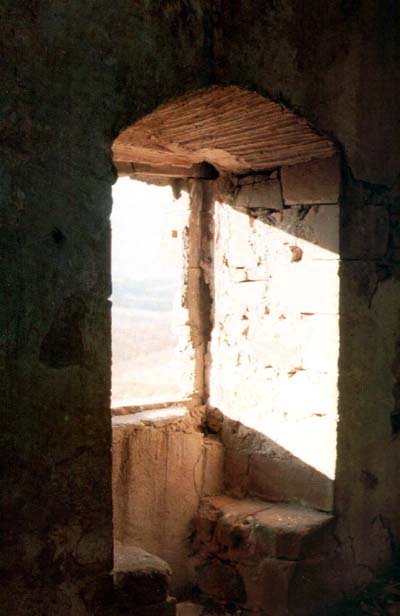 collegata
ad un ponte levatoio) non esiste più, solo i più sportivi, muniti delle
precauzioni del caso, potranno proseguire la visita. Al primo piano,
districandoci tra i detriti, troveremo
un vano (locale A della piantina 2)
che doveva svolgere la funzione di ingresso e da cui si accede sia alla scala C
che conduceva al piano superiore e sia all’ambiente B,
una stanza piuttosto curata e munita di una finestra con i due sedili tipici
dell’architettura medievale.
collegata
ad un ponte levatoio) non esiste più, solo i più sportivi, muniti delle
precauzioni del caso, potranno proseguire la visita. Al primo piano,
districandoci tra i detriti, troveremo
un vano (locale A della piantina 2)
che doveva svolgere la funzione di ingresso e da cui si accede sia alla scala C
che conduceva al piano superiore e sia all’ambiente B,
una stanza piuttosto curata e munita di una finestra con i due sedili tipici
dell’architettura medievale.
Da qui
la bella figlia del castellano, tessendo la sua tela, levava ansiosa lo sguardo
per scorgere nello sconfinato orizzonte l’apparire di un cavallo con in groppa
il principe azzurro dei suoi sogni. Seduta sul sedile di fronte, la madre, se
malmaritata, intonava invece antiche canzoni di lamento e di speranza per
l’arrivo di un cavaliere liberatore. Noi, più prosaicamente, ci limiteremo a
contemplare dalla finestra e dall’altra apertura della stanza “gli infiniti
spazi”, come li chiama Consolo, che la nostra terra sa riservarci.
Attraverso
la scala intagliata nella roccia che, come dimostrano gli 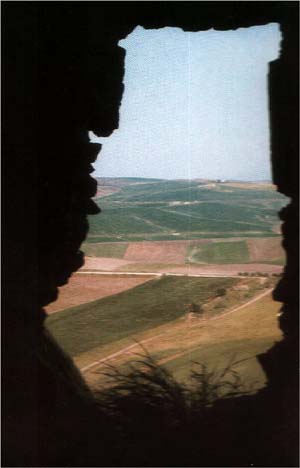 incassi
per i travetti lignei, doveva essere in parte sormontata da un ballatoio, dopo
due r
incassi
per i travetti lignei, doveva essere in parte sormontata da un ballatoio, dopo
due r ampe
ci troveremo in un corridoio (ambiente E
della piantina 3) che abbraccia l’intera larghezza dell’edificio e
quindi anche dello sperone roccioso a quella quota.
ampe
ci troveremo in un corridoio (ambiente E
della piantina 3) che abbraccia l’intera larghezza dell’edificio e
quindi anche dello sperone roccioso a quella quota.
Nell’estremità
occidentale si trovano i resti di una finestra che si affacciava sullo
strapiombo sottostante, mentre in quella orientale,
al termine del ballatoio si apriva una porta che, come scrive il Tomarchio,
“si affaccia assurdamente nel vuoto” e che, secondo lo stesso autore, poteva
servire come porta d’uscita per ospiti non graditi. Il corridoio delimita la
zona nord del castello costruita in muratura (a destra della cartina) da quella
costituita da una serie di caverne integralmente scavate nella roccia. Al suo
centro, una cisterna con tubazione di 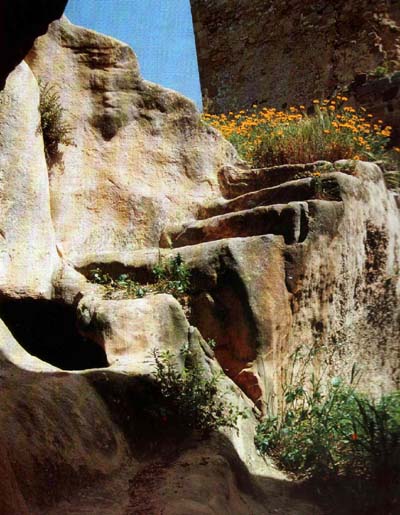 terracotta
incassata nella roccia che serviva a convogliare l’acqua piovana raccolta da
tetto. Nella parte destra, l’ambiente G,
ha perduto il pavimento ma l’intonaco ben rifinito, il portale d’accesso in
lava pregevolmente lavorata, il volto sorridente scolpito sull’architrave e la
volta con cupoletta ci rivelano la funzione “nobile” cui era destinato.
L’attiguo ambiente H era dotato di una
graziosa finestra ogivale sormontata da una bella lapide marmorea che molti di
noi ricordano e che é stata distrutta da sciagurati vandali in cerca di un
presunto tesoro. Da questa stanza, tramite un ballatoio di legno, si doveva
accedere alla torre. Dal lato opposto, invece, una caverna di forma allungata -
forse abitazione preistorica – che pareti in muratura suddividono negli
ambienti M, N ed O e dove troveremo una scritta in latino che evoca il diavolo ed
una sorta di affresco in bianco e nero rappresentante un misterioso personaggio
dalla lunga barba bianca, coperto da un mantello simile a quelli in uso nel
Cinque o nel Seicento.
terracotta
incassata nella roccia che serviva a convogliare l’acqua piovana raccolta da
tetto. Nella parte destra, l’ambiente G,
ha perduto il pavimento ma l’intonaco ben rifinito, il portale d’accesso in
lava pregevolmente lavorata, il volto sorridente scolpito sull’architrave e la
volta con cupoletta ci rivelano la funzione “nobile” cui era destinato.
L’attiguo ambiente H era dotato di una
graziosa finestra ogivale sormontata da una bella lapide marmorea che molti di
noi ricordano e che é stata distrutta da sciagurati vandali in cerca di un
presunto tesoro. Da questa stanza, tramite un ballatoio di legno, si doveva
accedere alla torre. Dal lato opposto, invece, una caverna di forma allungata -
forse abitazione preistorica – che pareti in muratura suddividono negli
ambienti M, N ed O e dove troveremo una scritta in latino che evoca il diavolo ed
una sorta di affresco in bianco e nero rappresentante un misterioso personaggio
dalla lunga barba bianca, coperto da un mantello simile a quelli in uso nel
Cinque o nel Seicento.
Riprendiamo la scala, percorriamo l’ultima rampa e ci troviamo su di un pianoro, il punto più elevato della grande roccia.
Entriamo
in quel che resta dell’ambiente P
(piantina 4) attraverso un portale ancora in piedi e ci troviamo in quella
che é stata forse la cappella del castello. Accanto ad essa, un basamento (punto
Q) che é tutto quello che resta dell’altra costruzione del quarto
livello. Noteremo anche un archetto in muratura sotto il quale si trova
l’apertura della profonda cisterna che raccoglieva l’acqua piovana dai tetti
di queste due costruzioni.